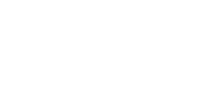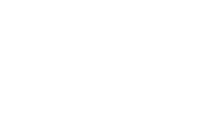Abbiamo incontrato tante volte Toraldo in questo ventennio di vita in cui 3D Produzioni ha raccontato sul web e in tv la storia e l’attualità del mondo del design e dell’architettura. Abbiamo avuto spesso bisogno della sua memoria, della sua visione, di un pensiero in cui sopravvivesse un po’ di utopia. Le interviste, eppur condotte davanti alla telecamera, si sono sempre trasformate in lunghe chiacchierate, non si risparmiava Toraldo, dava sempre più di quanto gli chiedevi. L’ultima volta è stato al MAXXI in occasione della mostra Superstudio 50, retrospettiva allestita nel 2016 per festeggiare i 50 anni dalla fondazione di Superstudio. Ne riportiamo una parte, un contributo alla memoria, un piccolo omaggio postumo.
Ci racconti come ha avuto inizio l’avventura Superstudio?
Erano i primi anni ‘60, un momento di passaggio critico per l’Italia: il boom economico si stava ormai esaurendo e le discussioni politiche si stavano facendo molto aspre. Quindi, anche all’interno delle università, cominciavano ad affiorare dibattiti. Nel ’63, con alcuni compagni dell’università che poi si uniranno a me nel Superstudio, abbiamo fatto la prima occupazione di facoltà per poter affrontare nuovi discorsi legati all’idea di architettura. Allora si pensava che l’architettura fosse un sistema di risoluzione di problemi; noi invece volevamo trasformare l’architettura in un sistema teorico, in un sistema di indagine dei problemi, in un laboratorio di ricerca del pensiero, insomma, in un pensiero politico.
Quali mezzi espressivi scelse Superstudio per comunicare le proprie idee?
La prima mostra del collettivo doveva essere una mostra di pittura, ma venne fuori una mostra che sfiorava i limiti dell’arte, dell’architettura e del design; una delle nostre preoccupazioni maggiori è sempre stata quella del superamento della disciplina, dell’ibridazione dei media, dei saperi, delle culture. Ci sembrava che l’architettura fosse troppo legata alla fiducia, oramai illusoria, che l’industria avrebbe risolto tutti i problemi dell’umanità, producendo l’oggetto definitivo. Questo ovviamente non successe, perché il mercato ha continuamente bisogno di nuovi modelli, necessari a rinnovare il desiderio del consumo. Quindi il mercato era ormai artificiale e noi eravamo dei componenti di questo mercato artificiale.
Cosa vi legava all’arte?
Adolfo Natalini era un pittore e faceva anche molte mostre; io ero un fotografo, mi guadagnavo da vivere con questo mestiere. Era una passione che veniva da lontano: mio padre, che era fisico e insegnava all’Università, in gioventù aveva progettato le lenti per la microcamera Ducati Sogno, piccolissima macchina fotografica prodotta subito dopo la guerra. Per tale motivo aveva installato nel bagno di casa una camera oscura e io, fin da bambino, mi appassionai alla fotografia. Una volta nato il Superstudio, lo scatto fotografico è diventato lo strumento di registrazione del nostro lavoro: appena finiti i disegni o i fotomontaggi, li fotografavo, e ancora oggi possiedo l’archivio fotografico del Superstudio.
Portavate avanti l’analisi di un mondo distopico, un po’ legato a quello della fantascienza?
L’idea del portare avanti questo mondo distopico in realtà è una visione che hanno avuto gli altri, perché il fatto stesso di chiamarci “super architetti” significava che volevamo essere all’interno del sistema, perché noi lo accettavamo in maniera molto realistica cercando di essere più irrealisti degli altri. Il nostro obiettivo era quello di immettere una fantasia rivoluzionaria nelle case degli italiani. Se noi fossimo stati subito considerati degli architetti radicali, fantastici, non avremmo avuto più alcun potere di lavorare all’interno dei deserti domestici, cioè deserti di creatività, luoghi nei quali il consumismo aveva tolto la possibilità creativa. Quindi, le prime produzioni, erano produzioni che cercavano di sconvolgere l’equazione secondo la quale la forma segue la funzione. Per noi la forma veniva prima e aveva la possibilità di creare delle nuove funzioni. Funzioni sensoriali ed emozionali. Dunque, con questa operazione di riempire i nostri oggetti di qualità tali da provocare amore o odio, cercavamo di produrre una forte reazione nel pubblico, provocando intenzionalmente una partecipazione alla creatività.
Siete stati solo dei teorici dell’architettura o avete progettato degli edifici che sono stati effettivamente costruiti?
Spesso si dice che non abbiamo mai costruito nulla, ma questo non è affatto vero perché noi eravamo dei super architetti e ci finanziavamo attraverso il lavoro di architettura pragmatica. Abbiamo fatto negozi, banche, edifici di tutti i tipi, ma sempre portando all’interno della professione nuovi materiali e nuovi sistemi di innovazione, gli stessi che portavamo nel design.
Il design, che in quegli anni rappresentava l’Italia creativa, vi permetteva di sperimentare maggiormente?
Sì, il design ci ha permesso di sperimentare tecniche diverse e di affrontare molteplici avventure. Per noi fiorentini è stato fondamentale il professor Cammilli, proprietario della Poltronova, un’azienda che aveva come art director Ettore Sottsass e che ha visto la collaborazione di Gae Aulenti, Superstudio, Archizoom e artisti come Max Ernst. Era un’azienda che aveva capito l’importanza di mescolare il design classico con le arti figurative ed era disponibile alle nuove sperimentazioni. Con loro abbiamo fatto le prime poltrone senza struttura, il Sofo. Successivamente Aurelio Zanotta ci chiese di produrre alcuni pezzi della serie Misura, che lui chiamò “Quaderna”. Durante la presentazione a Parigi di questa serie di tavoli lui fece fare per sé stesso e per tutto lo staff dei vestiti a quadretti, comprendendo il nostro spirito che vedeva l’architettura e la vita in dialogo, come una performance teatrale.

alla mostra
Superstudio 50
MAXXI 2016
foto Gabriele Mastrigli
Come nacque Quaderna?
Dopo il primo periodo di super architettura e super design, ci siamo resi conto che le nostre produzioni non facevano altro che alimentare il sistema, creando sempre più povertà e inducendo nuovi bisogni. Dunque perché focalizzarsi sulla qualità degli oggetti se potevamo lasciare sul tavolo una serie di quantità neutre a disposizione? Così nascono gli istogrammi, dei diagrammi tridimensionali di spazio che creano una griglia fatta di quadratini di 3×3 centimetri. Nel panorama culturale italiano dell’epoca sono stati un unicum.
Chi erano i vostri maestri?
I nostri maestri erano tutti gli architetti che avevamo conosciuto e studiato durante il periodo dell’università, non c’era un maestro unico. Anche il fatto stesso che noi non ci siamo chiamati con il nostro nome ma abbiamo scelto di fondare un collettivo, aveva questo significato. Proclamavamo la fine dell’architetto superstar. Chiaramente ognuno di noi aveva delle preferenze e degli interessi, ma quello che ci interessava era capire che cosa stava succedendo al di fuori dell’Italia. Dialogavamo e ci confrontavamo con i nostri colleghi esteri, ma ci distinguevamo da essi per via dell’impronta politica del nostro lavoro.