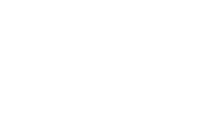CC La progettualità di FARM è trasversale, policentrica e intergenerazionale. Sempre legata ai luoghi, che sono dispositivi di progettualità, emancipazione e responsabilità del discorso pubblico. È un sistema virtuoso che si espande per cerchi infiniti, dalle persone alle comunità. Quindi Mazzarino, Favara, oggi Palermo, in parte Agrigento Capitale e poi vedremo cosa si aggiungerà. Ci racconti la genesi di questi progetti di vita che condividi con Andrea Bartoli?
FS La genesi dei progetti di vita che condivido con Andrea Bartoli, mio marito, è profondamente legata alla nostra visione di restituzione e impegno verso le comunità in cui viviamo. La nostra scelta di tornare in Sicilia non è stata solo una decisione personale, ma un atto consapevole di voler contribuire a un cambiamento positivo nel nostro territorio, utilizzando l’arte e la creatività come strumenti fondamentali per l’emancipazione sociale.
Farm Cultural Park, in particolare, è nato dall’esigenza di creare uno spazio che non fosse solo un centro artistico, ma un laboratorio di idee dove i cittadini possano confrontarsi su tematiche cruciali come lo sviluppo urbano, i diritti umani e la sostenibilità. Sin dall’inizio, il nostro obiettivo è stato quello di rendere l’arte accessibile a tutti e di utilizzarla come catalizzatore per una riflessione profonda sulle sfide contemporanee che ci circondano.
Ogni progetto nasce da una interazione autentica con il contesto locale. Mazzarino e Favara hanno rappresentato i primi passi di questo percorso, dove abbiamo cercato di sviluppare iniziative che rispondessero alle esigenze e ai desideri della comunità. Il 2024 ci ha regalato la possibilità di arrivare a Palermo, dove non potevamo che mettere a valore la sua interculturalità attraverso la nascita del Museo delle città del Mondo, l’evoluzione naturale della Biennale delle Città del Mondo di Farm, che ha già messo in evidenza l’importanza del dialogo tra le culture urbane e la loro interazione. Con il Museo, Farm intende rafforzare questo impegno, creando uno spazio permanente dove le storie delle città possano essere condivise, esplorate e celebrate, promuovendo una comprensione più profonda delle diverse identità urbane e un impegno collettivo per la pace, la libertà e il rispetto dei diritti umani.
La progettualità di Farm è caratterizzata da un approccio trasversale e policentrico. Di fronte alla complessità di problemi difficili da affrontare, siamo consapevoli che trovare soluzioni semplici o operare in compartimenti separati non è l’ideale. Pertanto, riteniamo fondamentale adottare un approccio sistemico e transdisciplinare, in grado di considerare le interconnessioni e le relazioni tra gli elementi coinvolti. Ci impegniamo a stimolare un dialogo continuo tra diversi gruppi generazionali e culturali, creando un sistema che, pur non riuscendo sempre, aspira ad arricchirsi di esperienze condivise e nuove idee.
La nostra visione è quella di coinvolgere le comunità in un processo collettivo di cambiamento, in cui l’arte non rappresenti solo una forma di espressione, ma diventi un mezzo per affrontare e risolvere le sfide che riguardano tutti noi. Siamo fermamente convinti che, tramite la partecipazione attiva e l’impegno condiviso, possiamo contribuire a lasciare un segno positivo e duraturo nel mondo in cui viviamo.

CC Le scelte curatoriali e artistiche – che siano arte, recupero, restauro, nuova architettura – da quali criteri sono ispirate? Quali autori e perché?
FS Le scelte curatoriali e artistiche di Farm Cultural Park sono guidate da una profonda riflessione sui valori che vogliamo promuovere all’interno della nostra comunità. Puntiamo a sostenere artisti che, oltre a condividere questi valori, possano stimolarci a riflettere su temi importanti attraverso il loro lavoro. Non ci limitiamo necessariamente a collaborare solo con artisti affermati; al contrario, spesso ci troviamo a lavorare con artisti molto giovani. Questa scelta è dettata dal fatto che, essendo meno legati alle dinamiche di mercato, hanno la libertà di esprimere la loro creatività senza vincoli, portando freschezza e innovazione nei nostri progetti.
Inoltre, a volte lavoriamo con persone che non si considerano necessariamente artisti, ma di cui noi riconosciamo il valore artistico delle opere. Crediamo fermamente che l’arte possa emergere da svariati contesti e background, e che ogni forma di espressione creativa possa contribuire al dibattito culturale della nostra comunità. Per quanto riguarda la scelta dei luoghi e la loro rigenerazione o recupero architettonico, tendiamo a dire di avere una sorta di “sindrome ossessiva compulsiva di trasformazione”. Quando visito uno spazio, percepisco quasi istintivamente il suo potenziale trasformativo. Più un luogo è distrutto, più ne rimango affascinata, forse perché in esso vedo maggiori margini di intervento e opportunità di rinascita. Questo desiderio di trasformazione è intrinsecamente legato alla nostra missione: dare nuova vita a spazi che hanno bisogno di attenzione e cura.
Siamo molto influenzati dai nostri viaggi: ogni esperienza arricchisce la nostra visione. In questi anni, ci siamo lasciati guidare anche dall’istinto, il segreto, però, è la continua ricerca, sperimentazione e studio. Vogliamo creare un ambiente in cui arte, recupero, restauro e nuova architettura dialoghino tra loro, contribuendo a un dibattito vivace e stimolante all’interno della nostra comunità.
CC Con Andrea avete attivato una sorta di “diplomazia culturale” a geometria variabile che permette di espandere il network e le opportunità. Anche in questo caso il metodo fa la differenza. Qual’è lo schema che ricorre?
FS La nostra idea di “diplomazia culturale” è nata quasi per caso, durante i primi passi mossi a Mazzarino, quando abbiamo deciso di ristrutturare la nostra casa, un palazzo settecentesco carico di storia e fascino. Durante i lavori di ristrutturazione, ci siamo resi conto di una cosa profonda: non avremmo mai potuto godere da soli di tutta quella bellezza. Era troppo grande, troppo significativa per rimanere chiusa tra noi in quattro mura. Sentivamo che quel patrimonio doveva essere condiviso, aperto a chi avrebbe potuto apprezzarne la storia, respirarne l’anima e trarne ispirazione. La condivisione, per noi, non era solo un gesto di apertura, ma una necessità: un modo per far vivere quel luogo attraverso gli occhi, le esperienze e le emozioni degli altri.
In quel momento, abbiamo avuto la conferma che la cultura e l’arte sono linguaggi universali, capaci di parlare a tutti, di unire, di curare. In un’epoca come la nostra, segnata da conflitti, ingiustizie e disuguaglianze, la cultura non può limitarsi a essere uno spettacolo. Deve diventare uno strumento di cura, di coesione sociale, di rinascita. È da questa consapevolezza che è scaturita l’idea di aprire casa nostra, trasformandola in un’ambasciata culturale, un luogo di scambio e dialogo. Non volevamo solo un luogo figo e borghese, ma uno spazio vivo, dove accogliere non solo artisti, ma soprattutto direttori di musei, istituzioni culturali e pensatori da tutto il mondo. Un luogo dove ridiscutere il ruolo della cultura come strumento di diplomazia, come ponte tra le persone e come motore di cambiamento. La condivisione, in questo senso, è diventata il cuore pulsante del nostro progetto: condividere spazi, idee, visioni e speranze. Il metodo che abbiamo scelto si basa sull’accoglienza e sulla generosità. Crediamo che ogni persona debba sentirsi parte di qualcosa di più grande, di una comunità che la valorizza e la rispetta. Cerchiamo di creare un ambiente in cui tutti possano essere se stessi, esprimersi liberamente, senza paura di essere giudicati. È attraverso questa apertura che nascono relazioni autentiche e durature, che si trasformano in un network culturale dinamico, in continua espansione. Una rete “a geometria variabile”, che si adatta, si trasforma e si arricchisce con ogni nuova connessione. La condivisione, in questo contesto, non è solo un atto di apertura, ma una pratica quotidiana: condividiamo spazi, risorse, conoscenze e opportunità, perché crediamo che solo insieme si possano costruire ponti veri e duraturi.
Questo approccio, che mette al centro l’inclusione, il dialogo e la condivisione, ci permette di rafforzare il ruolo della cultura come ponte tra comunità diverse, stimolando opportunità di crescita e sviluppo reciproco. Il nostro obiettivo è trasformare il patrimonio che abbiamo ereditato non solo in un bene materiale, ma in un catalizzatore di cambiamento sociale e culturale. Perché crediamo che la cultura, quando è condivisa e vissuta collettivamente, possa davvero cambiare il mondo, un passo alla volta.

CC L’architettura insegnata ai bambini: come nasce e con quale motivazione? Su quali skill poggia e cosa si ripromette di ottenere?
FS L’idea di insegnare l’architettura ai bambini è nata da un’intuizione semplice ma profonda: i bambini sono naturalmente curiosi, creativi e capaci di guardare il mondo con occhi liberi da pregiudizi. Inizialmente, avevamo pensato di realizzare un Children’s Museum, ma ci siamo scontrati con la mancanza di risorse. Tuttavia, non abbiamo rinunciato all’idea di lavorare con i bambini, perché crediamo fermamente che sia nostro dovere restituire loro la dimensione del gioco, della possibilità e della scoperta. Volevamo creare uno spazio in cui potessero alimentare il pensiero critico, esercitare l’intelligenza emotiva e, soprattutto, sentirsi liberi di esprimersi. Perché proprio l’architettura? Perché questa disciplina offre un terreno fertile per l’apprendimento. Permette ai bambini di esplorare lo spazio che li circonda, di comprenderlo e di riflettere su come vorrebbero che fosse. E, soprattutto, ci insegna a non sottovalutare la loro capacità di osservazione e la loro creatività innata, fonti di idee sorprendenti. La nostra scuola, nata a Favara come un piccolo esperimento, oggi ha 25 sedi in tutta Italia.
Questo ci riempie di orgoglio, ma anche di una grande responsabilità. Ogni bambino che partecipa ai nostri laboratori ci ricorda quanto sia importante investire nel loro futuro. Le skill su cui poggiamo sono molteplici: la creatività, il problem solving, la collaborazione, ma anche l’ascolto e l’empatia. Vogliamo che i bambini non solo imparino a progettare, ma anche a sentirsi parte di una comunità, a rispettare gli spazi condivisi e a immaginare un mondo migliore. Ciò che ci ripromettiamo di ottenere è semplice ma ambizioso: vogliamo che i bambini crescano con la consapevolezza di poter fare la differenza. Che siano cittadini attivi, critici e sensibili, capaci di guardare al futuro con speranza e determinazione. Perché, in fondo, l’architettura non è solo una questione di mattoni e cemento: è una forma di cura, un modo per prendersi cura delle persone e dei luoghi che abitiamo. E i bambini, con la loro purezza e il loro entusiasmo, sono i migliori maestri in questo percorso.
CC I vostri progetti sono allo stesso tempo molto popolari e molto disciplinari, piacciono agli addetti ai lavori e si fanno comprendere dalle persone. Su cosa poggia questa chimica fine? Sono dispositivi che fanno succedere cose, relazioni, progetti?
FS I nostri progetti affondano le radici in una chimica speciale, quasi magica, che nasce dall’incontro tra la passione per la cultura, un profondo rispetto per il territorio e una volontà di inclusione. Quando io e Andrea siamo tornati in Sicilia da Parigi, portavamo nel cuore una convinzione chiara: i luoghi possono cambiare, e questo cambiamento è guidato dalle persone. Quello che avevamo visto e amato a Parigi, sapevamo di poterlo ricreare a modo nostro e con le giuste proporzioni in Sicilia. A Favara, avevamo il sogno di creare una comunità vivace, creativa e inclusiva, quasi una missione. Questo approccio ci ha spinto a lavorare con un obiettivo preciso: migliorare il nostro contesto, adottando una mentalità preparata, competitiva e innovativa, ma senza mai perdere di vista la realtà locale. Abbiamo sempre cercato di mantenere un linguaggio e uno storytelling semplici, ma mai banali, perché crediamo che per comunicare efficacemente sia fondamentale essere autentici. Volevamo che le nostre iniziative parlassero alle persone, non solo agli addetti ai lavori. Volevamo creare un ponte tra il mondo dell’arte e la comunità, perché la cultura, per noi, è prima di tutto condivisione.
Una delle chiavi del nostro successo è stata anche la capacità di lavorare con i bambini. Questo ci ha permesso di arrivare alle famiglie e di creare un legame più profondo con la comunità. I bambini sono i migliori ambasciatori di un’idea: il loro entusiasmo, la loro curiosità e la loro purezza ci hanno aiutato a coinvolgere genitori e familiari, trasformando il nostro progetto in qualcosa di collettivo e inclusivo. Attraverso di loro, abbiamo capito che il cambiamento parte dalle piccole cose, dai gesti quotidiani, dalla voglia di giocare e di immaginare.
I media, in particolare Rai Uno, ci hanno dato una legittimazione importante, soprattutto nei confronti di chi, all’inizio, faticava a comprendere quello che stavamo facendo. Grazie alla copertura mediatica e alle storie che abbiamo condiviso, abbiamo dimostrato che le nostre iniziative non avevano solo un valore artistico, ma potevano contribuire attivamente al benessere della comunità. Questo ci ha permesso di portare la nostra visione a un pubblico più ampio, più comune, più vero.
Farm non ha mai nascosto le sue fragilità, e forse è proprio questo che l’ha resa più vicina alle persone. Abbiamo sempre spiegato apertamente cosa facciamo, confrontandoci anche su quelle scelte che potrebbero sembrare banali per noi, ma che hanno un significato profondo per gli altri. Vogliamo assicurarci di non lasciare nessuno indietro. Perché la cultura, per noi, non è mai stata una torre d’avorio: è un luogo di incontro, di scambio, di crescita collettiva.
Questa “chimica fine” di cui parlo deriva dalla capacità di progettare dispositivi che favoriscano interazioni significative e sviluppino relazioni, sia tra le persone che tra le idee. Lavoriamo per creare spazi e occasioni in cui le idee possano germogliare e fiorire: produzioni artistiche, eventi, collaborazioni. Ogni progetto è pensato per stimolare il dialogo e l’incontro tra culture diverse, tra artigiani e artisti, e per invitare la comunità a sentirsi parte di un processo creativo collettivo. In questo modo, siamo riusciti a costruire un ecosistema culturale che è accogliente, stimolante e aperto alla partecipazione. La popolarità dei nostri progetti è un riflesso del fatto che il nostro approccio risuona con le persone, creando un senso di appartenenza e una connessione profonda con il territorio. Siamo convinti che il cambiamento passi attraverso le relazioni e la collaborazione, e siamo felici di assistere a come tutto ciò possa realmente accadere in un luogo che riteniamo possa diventare un faro di creatività e innovazione. Perché, in fondo, Farm non è solo un progetto: è una storia di persone, di sogni e di fragilità trasformate in punti di forza.