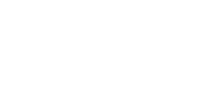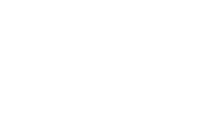“Nella nuda e palese compagine del fattuale, l’originario non si dà mai a conoscere, e la sua ritmica si dischiude soltanto a una duplice visione. Essa vuol essere conosciuta quale restaurazione, non ripristino da un lato e, dall’altro e proprio per questo, da un che di imperfetto e non conchiuso.”
W. Benjamin, Il dramma barocco tedesco, Torino 1971, p. 29.
Mi piace pensare che dopo aver tanto professato l’immagine come una sorta di sintomo fluente, di catastrofe interna allo sviluppo in divenire, si possa tornare di nuovo all’idea di origine-sorgente, seppur relativa all’individuo e non legata ad una diversa metafisica. Un concetto che parte, nella poetica in questione di Benedetta Giampaoli, dalla constatazione del sé per una diversa esigenza espressionistica. Come afferma l’artista, i suoi sono strumenti individuali che cercano di afferrare la crisi del tempo, inteso come spazio discontinuo.

“Gli occhi sono gli organi ‘mobili’ attraverso i quali percepiamo il mondo. La pittura nasce dagli occhi, successivamente viene eseguita dalla mano. Ogni immagine è un gioco, un tranello, un’ambigua verità. Nella mia ricerca mezzi come il disegno, la grafica e la pittura vengono utilizzati per dare forma a questi racconti di immagini stralunate in cui la figura ha un ruolo protagonista: in particolare quando non è presente.” E ancora: “Non esiste mai un tempo definito dove si collocano le immagini: tutto si dilata e allo stesso tempo tutto converge; costante è la necessità del fallimento di un soggetto, scoprire il punto debole, masticarlo e sputarlo nuovamente, diverso, sotto una rinnovata pelle.” In questo senso vi è sempre un processo di contatto, per una ricerca di autenticità tutta personale pur rimanendo nella traccia di una necessità pittorica che rimanda necessariamente agli anni Ottanta. Sempre ribadendo questa differenziazione fra un concetto di origine e di genesi, l’autrice afferma: “Metamorfosi continue accadono in particolare all’interno delle tele: alcuni elementi tendono a ripetersi ma riproponendosi diversi nel passaggio da una tela all’altra, a volte quieti dei loro nuovi abiti, altre sconvolti come se non trovassero mai uno specchio in grado di riflettere la vera identità del loro aspetto. Ogni lavoro parte dalla necessità di non comprendere a fondo e razionalmente un’immagine bensì di vederla nascere segno dopo segno e stupirsi del colore o della forma che prende, di esaltare e preservare l’entusiasmo di una bugia, proprio come un bambino che modella il pongo.”
Questo recupero del lato quasi pre-iconico, infantile, fa sì che anche l’atteggiamento nel fare pittura non solo non sia rispondente ad una analisi logico-razionale ma che le modalità di attuazione abbiano un fare rabdomantico, quasi che le immagini necessitino di una dimensione aliena dalla concentrazione, dalla focalizzazione di un tema. “I dipinti spesso nascono quando sono distratta, quando ragiono a tutt’altro perché solo così riesco a sentire con una naturalezza e con una certa libertà ciò che mi circonda: un pensare che figuro nella mia testa come quello di un fiume, un flusso di sensazioni e immagini che nuotano incessantemente, alle volte unite e aggrovigliate fra loro, altre che addirittura s’affogano.”
Forse, per contatto.