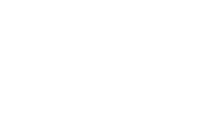Cercare di raccontare la relazione tra queste due azioni architettoniche a partire dall’etimo filosofico è un’impresa ardita e ambiziosa. Se poi ai verbi, per definire l’azione nello spazio, nel tempo o nelle modalità, si prova ad associare l’avverbio “poeticamente”, allora il tentativo diventa utopia. Non me ne vorranno gli estimatori di Hölderlin – il grande poeta tedesco – o anche solo quelli di Vitta – filosofo e autore di Dell’abitare. Corpi spazi oggetti immagini (Einaudi, 2008). Preferisco non inoltrarmi in questo territorio pericoloso. Mi limiterò a usare i termini in gioco per descrivere un fenomeno che sembra ormai prendere campo anche nelle nostre città, strutturalmente lontane dalla dimensione e dai flussi dei grandi centri di produzione e promozione culturale. Case atelier, case gallerie, musei domestici – o come li vogliamo chiamare – si affacciano sempre più numerosi nella scena urbana marchigiana. Non si tratta di case museo, né di case d’artista (come quelle storiche della Tuscia viterbese), ma di abitazioni private, dimore che diventano spazi espositivi, che ibridano la dimensione intima del rifugio domestico con l’azione rappresentativa della galleria e del museo. Si tratta quasi sempre dell’esito di progetti di recupero che attraverso poche, ma profonde azioni di trasformazione, aprono gli spazi domestici a usi “altri”, che si sovrappongono a quelli che associamo generalmente al salotto o alla sala da pranzo, fino a sfumarne i contorni.
Una “vita nuova” della casa che estende le funzioni dell’abitare dentro quelle della vita, pubblica e culturale, che, invece di ritrovarsi ingigantita dalla creatività intrinseca alla vita museale, si sovrappone a modi di essere esercitati nei luoghi dell’intimità. Nella storia dell’architettura italiana, gli scambi fra l’esporre, l’allestire e l’abitare sono stati riconosciuti da una vasta bibliografia come “l’educazione pratica” che ha segnato fortemente la formazione dell’immaginario e la concezione spaziale di Gardella, dei suoi coetanei BBPR e Albini o dei successivi Scarpa e Riva. Il confinamento forzato nel mondo effimero delle esposizioni, degli allestimenti fieristici come nei piccoli interventi di arredamento all’interno di abitazioni preesistenti, costituisce il teatro di prova in cui è possibile sperimentare, nello spazio della casa, l’allestimento e il dialogo fra oggetti antichi e nuovi, fra materiali artigianali e opere d’arte, tra testimonianze della memoria e prodotti all’avanguardia, fra il silenzio contemplativo e la sua dimensione espressiva. In questo senso, le stanze di queste case-galleria sono “scene ALTRE” che si attivano in un continuo scambio di immaginari e tecniche compositive a partire dalla disponibilità degli spazi ad accogliere simultaneamente opere e arredi, rappresentazioni del mondo ed espressioni dell’intimità. Per un tempo limitato e sempre diverso.
Uno degli aspetti di maggior interesse di queste case ibride sta nella forma della soglia tra la parte lasciata all’intimità e la porzione resa disponibile alla ostensione delle opere, sia essa uno spazio di passaggio e di transizione o una semplice porta, separazione minima, opaca o trasparente. Un dispositivo che separa e connette allo stesso tempo, che segna la transizione dell’uso e la misura del tempo. Capire dove questa soglia è posizionata, nell’articolazione degli spazi della casa, significa capire fin dove l’abitante sceglie di ex-porre sé stesso e quali sono gli spazi destinati al rifugio e alla cura di sé.
Il secondo aspetto su cui porre attenzione è l’organizzazione dell’abitare in relazione alla presenza del vuoto necessario per ospitare le COSE da mostrare. Lo spazio architettonico di una casa è sempre mediato da un apparato funzionale, l’arredamento, che dà ordine e dà luce allo spazio intimo della dimora. Una volta accettata la presenza di “altre cose”, che occupano anche solo temporaneamente come ospiti (indesiderati?) lo spazio del quotidiano, che valore assumono i divani, i tavoli, le poltrone, le sedie, i lampadari? Che ruolo hanno nel definire che soggiorno e sala da pranzo sono sale espositive e non solo spazi dove riposare e mangiare? Che senso assumono nella vita domestica le luci tecniche, utili per migliorare la visione di una foto d’autore, o le sedute necessarie per meglio stare di fronte a un’opera d’arte? In alcuni casi si fa fatica a scegliere cosa tenere. Si può optare per la compresenza, per l’indifferenza, per la selezione. A volte l’arredo scompare, a volte ne rimane una traccia, un residuo, a volte organizza totalmente lo spazio in una virtuosa relazione con le opere in mostra.
In questo numero sono presentati tre esempi diversi di case galleria: tre diversi approcci all’abitare per tre diverse declinazioni dell’esporre, tre diverse articolazioni degli spazi per tre diverse interpretazioni del tema della soglia. Tre diversi rapporti con il contesto basati su tre diversi modi di gestire le aperture e le viste. Tre case per tre gallerie.
PS 1. Casa e arte hanno un legame misterioso che trascende l’ordinario abitare. Definiscono uno spazio di vita e di creazione complesso perché la storia della casa si intreccia con la storia di chi la abita e del suo rapporto con il contesto in cui vive. Ed è illusorio ridurla a un tipo architettonico facilmente riconoscibile e corrispondente a specifiche caratteristiche fissate una volta per tutte. Quindi, studiare le case che diventano spazi di esposizione per l’arte significa soffermarsi sulla loro essenza ibrida, indugiare sulla soglia della loro indeterminatezza. Due caratteristiche che suscitano, in modo perturbante e inevitabile, la questione del nostro abitare il mondo.
PS 2. La parola “altre” non indica soltanto l’intenzione di occuparsi dell’inedito e degli aspetti forse non del tutto compresi o a volte tralasciati da una critica prevalentemente rivolta alle architetture di grande potenzialità iconica. Significa accettare anche la possibilità di aggiungere materiale di indagine al progetto di architettura degli interni, attraverso le sistemazioni espositive o gli allestimenti effimeri. Esiste “un legame sottile ma continuo” tra i progetti di grandi architetture e la ricerca sullo spazio interno. Il lavoro negli interni costituisce un luogo più aperto alla sperimentazione e meno noto della ricerca. In esso le questioni d’architettura, affrontate nella città o nel paesaggio, riaffiorano, si trasformano o, forse, prendono forma. Comunque si avvalgono di una reciprocità sperimentale.
PS 3. Le cose hanno a che fare con ciò che coinvolge affettivamente le persone. Spesso una cosa, è investita di affetti, caricata di interpretazioni e di simboli. Amando e rispettando le cose nella loro singolarità, intrecciamo con esse un legame unico che ci spinge a innalzarle dalla loro condizione precaria e a trasformarle in piccoli frammenti di eternità. Come accade per un’opera d’arte. A partire dal momento in cui si decide di affidarsi al potere ordinatore delle cose, una mera scatola tridimensionale può trasformarsi nello spazio intimo di una casa o in un ambiente pronto ad ospitare un racconto espositivo.