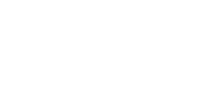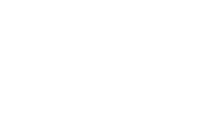È accaduto tanti anni fa, e ancora mi meraviglio nonostante tutto.
“Vi mando il girato sulla Chietese” “Ma questa è Ancona”. “Perché? Ancona non sta in Abruzzo?”. Ora, direte voi, tanti romani – ancor più se dipendenti Rai – sono certi che fuori dall’Urbe il mondo sia in gran parte popolato da indistinte orde barbare.
Epperò per tutta la vita ho dovuto far i conti con l’anonimità della terra in cui sono nata.
Da quando, ancora studentessa, un altro marchigiano adottato a Bologna, un grande però, Andrea Pazienza, vergò per Il Male la maledetta fulminante “Le Marche una regione dove vivere dimenticati”. Che in realtà era nata come “morire dimenticati”, ma persino quegli irriverenti scelsero di attenuare il lucido sberleffo. Dimenticate, fuori dai confini dell’impero, “e pensare che c’è un sacco di gente che vive e lavora a Macerata”. Me ne sono fatta una ragione quando lessi, non ricordo più dove e quando, un economista, marchigiano anch’egli, Geminello Alvi, spiegare che nelle Marche si viveva più a lungo perché prive della magnificenza che intimorisce, da Venezia (anche nel faticoso inferno di assedianti) a Ortigia. Insomma, la medietà marchigiana, che per Piovene era merito, era aurea mediocritas che non perturbava gli animi. D’altra parte non è sempre stato Alvi a definirla la regione più noiosa d’Italia? O Franco Arminio a raccontarla come una corsia di lungo degenza? Sono nata in una lunga striscia di scogli sconosciuta anche a sé stessa, che vive su due mari – raccontò Pierpaolo Pasolini – ma con il passeggio in terraferma, un corridoio di cemento dove i due mari non si vedono. Le mie Marche sono state, da lungi, luogo di passaggio in attesa di qualcosa di definitivo, da cui fuggire perché era possibile tornare, per bisogno e diritto di affettuosi pettegolezzi su eroiche gesta dentro le mura, dove il tempo era sospeso, tranquillitas rerum.

Osvaldo Licini, Amalassunta su fondo blu 1955
Immagini courtesy Galleria d’Arte Contemporanea “Osvaldo Licini”, Ascoli Piceno
Come Elcito, uno sperone di roccia al centro di un altopiano verdissimo, completamente nascosto dentro una corona di monti, l’unica stradina che porta solo lì, il Tibet d’Italia chiamano quel gruppo di case ferme al Duecento. Una fiaba da cui vedere il mondo ma dal mondo protetto il wifi attivo solo in tre privilegiati punti (non li svelerò nemmeno sotto tortura), a venti chilometri le botteghe più vicine per fare spesa, bere un caffè, e non parliamo di giornali. Sopra la superba faggeta di Canfaito. Magico rifugio. Sciagurata sia l’omologazione che non permette più di sfuggire all’ansia. Avevo imparato a conoscere certa Italia dalle informazioni sul traffico. Tipo Roncobilaccio, Barberino di Mugello, i punti di maggiori ingorghi, incidenti, insomma dove la vita e i tormenti scorrono.
Le Marche erano saltate a piè pari, sempre, ignote, come ai montatori Rai. Da tempo, invece, ogni mezz’ora sono più citate della Salerno Reggio Calabria: “incidente tra Pedaso e Porto d’Ascoli”, “cinque chilometri di coda tra Grottammare e Porto Sant’Elpidio”, senza tregua.
Le Marche del limbo dantesco sono mutate dalla stempiata pragmatica attesa all’inquietudine. Elcito è fatato, ma non ci sono più abitanti, solo seconde case e, in certi periodi dell’anno, arrivano tanti affamati che sembra di stare a piazza San Marco durante il Carnevale. Benvenuti nel mondo, dice un amico. Per Arminio, il poeta paesologo, le Marche sono “un ottimo luogo per vedere a che punto è la nostra febbre”. Non sopporto questa banale notorietà.